Buon lunedì 20 gennaio,
qui è tutto molto ovattato. Fuori è grigio e fa freddo. È morto David Lynch e io non me ne faccio una ragione. Mi sento avvolta da grigio pure io e credo sia questo periodo. Ma forse è l’effetto del blue monday?
Nel frattempo, però, è anche iniziato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e sento più speranza, nonostante la paura.
Io sono Tatiana e questa è la newsletter di Kanji, quella che parte ogni lunedì mattina (e a volte il martedì) per arrivare alla tua casella di posta. Se te l’hanno inoltrata e vuoi iscriverti, puoi farlo da qui.

«Il mondo è diventato una stanza rumorosa, il silenzio è il luogo magico in cui si realizza il processo creativo.»
David Lynch
Presumere di sapere, interpretare i dati e progettare una ricerca
Qualche settimana fa, una persona mi ha raccontato tutta orgogliosa di aver preparato e somministrato un’indagine per capire il livello di gradimento del suo lavoro. Un po’ come quei questionari che arrivano dopo aver acquistato un prodotto o dopo aver frequentato un corso. L’indagine era una survey online con serie di domande chiuse dove esprimere un gradimento per diverse categorie con una scala da 1 a 5 (1> non soddisfazione e 5> molta soddisfazione).
La persona mi dice che ha ricevuto molte risposte, soprattutto positive tranne due, aggiungendo “probabilmente chi ha compilato non ha capito”.
Premesso che l’indagine non l’ho vista, letta e nemmeno compilata, ho riflettuto molto su questa interpretazione del dato e non solo. Mi sono anche chiesta su quale base abbia scelto una survey per indagare la soddisfazione del servizio. Mi sono chiesta se questa indagine l’abbia progettata o abbia solo creato un Google form. In realtà, una domanda l’ho posta: «come hai progettato l’indagine?» Non ho ricevuto risposta.
Andiamo con ordine.
La prima domanda da farsi
Fare ricerca significa sospendere i secondo me, forse sarebbe meglio se, io farei così. Se si vuole fare ricerca e farla come si deve, serve progettare. Serve farsi buone domande. Serve fermarsi. La prima cosa da fare è scrivere il documento di strategia che metta nero su bianco le ipotesi di partenza e ciò che ci si aspetta di ottenere.
Come ricorda anche Raffaella Roviglioni nel suo libro Chi vuole cavalli più veloci? Allenare ascolto e curiosità nella ricerca con le persone capita spesso che chi è a capo di un’azienda abbia già una chiara idea di chi siano i clienti e di cosa vogliano e di non mettere mai in discussione queste idee. Se non chiedere è una pessima idea, allo stesso modo lo è fare ricerca e interpretare i risultati secondo i propri desiderata.
Tornando alla mia esperienza, la persona dicendomi quel “probabilmente chi ha compilato non ha capito” non ha voluto indagare il perché di quel dato andando in profondità, ma presumendo che fosse chi ha risposto alla survey a non aver capito.
«Dietro le risposte delle persone si celano storie, bisogni e motivazioni, e se non le comprendiamo a fondo, non riusciremo mai a proporre soluzioni in grado di innovare - e magari migliorare – il loro mondo.»
Raffaella Roviglioni, Chi vuole Cavalli più veloci?
Non basta fare domande. Serve porre quelle giuste.
Sulle domande giuste ne ho scritto tanto. E anche sulle domande sbagliate, quelle che portano fuori strada. Le buone domande sono quelle che indagano l’essenza, quelle scomode, quelle che mettono in discussione lo status quo. Se si fanno domande solo per confermare le proprie credenze non si sta facendo ricerca. Se poi, quelle domande sono pure poste male, beh, a cosa è servito indagare?
«Because anything worth doing is worth questioning to verify whether it’s actually worth doing.»
Erika Hall
Nello stesso articolo, Erika Hall ha formulato cinque domande che le aziende dovrebbero porsi e la prima è molto interessante perché riguarda proprio la capacità e la volontà di ammettere di non sapere qualcosa.
Fare ricerca (qualsiasi tipo: qualitativa e quantitativa) è uno spazio di apprendimento e ammettere di non sapere e conoscere è l’incipit di una innovazione: per migliorare qualcosa, sia esso un processo, un servizio o un prodotto che in qualche modo intercettino i bisogni delle persone, rispondano a necessità e offrano esperienze piacevoli e utili.
La ricerca aiuta il business a non commettere l’errore di progettare per sé stesso seguendo quello che si chiama effetto del falso consenso (un bias), invece di scoprire opportunità e, sì, l’inaspettato.
Interpretare i dati
L’analisi dei dati di una ricerca è l’immersione profonda in quel caos rappresentato dalla risposte ottenute durante la fase esplorativa. In questa fase è facilissimo cercare scorciatoie e perdersi nei pregiudizi, fallendo la vera comprensione.
Parafrasando una parte dell’ultima Linguetta di Andrea M. Alesci, spesso sono il contesto o l’intenzione a dirci come leggere e interpretare i dati.
Ecco perché è fondamentale avere una buona domanda di partenza (il documento di strategia che ho citato all’inizio) che possa guidare non solo la progettazione della ricerca, ma anche la somministrazione dell’indagine e la sintesi dei risultati, per non commettere l’errore di interpretare in modo superficiale o errato quanto emerge.
Se l’intento è solo di darsi una pacca sulla spalla e non cambiare nulla di quel che è lo status quo, non fare ricerca. Basta guardarsi allo specchio.
A presto,
Tatiana (e Chiara)
📃Abbiamo parlato di
📍Cose che hanno lasciato un segno
Domanda e offerta nella professioni digitali: perché spesso non si incontrano
La vita dopo l’autonomia. Le parole di Mariachiara Montera su Il Post
Cosa significa cancellare i programmi di diversità, equità e inclusione?
Quanto è sensato valutare l'essere umano insieme all'opera d'arte che ha prodotto? Un post su LinkedIN a proposito di Neil Gaiman
Persone trans e discriminazioni sul lavoro: Donata Columbro intervista Isa Borrelli sull’ultima indagine Istat
📚🎧📺 Stiamo leggendo/ascoltando/guardando
Le letture, gli ascolti e le visioni di Chiara
Ho finito di ascoltare il pregresso di Tutti gli uomini, di Irene Facheris, e non vedo l'ora arrivi la prossima puntata, per continuare a immergermi in un mondo così simile e profondamente diverso dal mio, quello degli uomini appunto.
Dopodiché ho iniziato ad ascoltare Sigmund di Daniela Collu per Il Post e mi sta piacendo moltissimo.
Mi sono però resa conto che nella prima puntata mi urtava sentire due donne, Daniela e l'ospite, che parlavano utilizzando in modo diffuso e sistematico il maschile sovraesteso. È stato difficile da tollerare dopo la maratona Tutti gli uomini (dove invece c'è un'attenzione massima all'espressione di genere) ma, triste dirlo, nel giro di due episodi mi ci ero già riabituata.
Lato video, sto facendo una piccola incursione negli amati k-drama, con Love next door, su Netflix, sperando prima o poi di incappare in un altro Cloy (Crash Landing On You).
Le letture, gli ascolti e le visioni di Tatiana
Letture. Ho messo momentaneamente in pausa Mostri. Distinguere o non distinguere le vite dalle opere: il tormento dei fan di Claire Dederer, e proseguo con Intermezzo di Sally Rooney e con Confessioni di un marketer di Enrico Marchetto che ho quasi finito. Intervallo la lettura di libri con newsletter e articoli e soprattutto podcast.
Ascolti. Oltre ai soliti ascolti dei podcast de Il Post, continuo ad amare Orazio, Una notizia al giorno e le storie che le stanno attorno, ogni pomeriggio per tutto l’inverno di Matteo Caccia. Puntata dopo puntata mi regala sempre qualcosa su cui riflettere, per esempio la storia de Gli Hibakujumoku ovvero i reduci della bomba atomica. Da gennaio 2025, molti tra i podcast de Il Post sono riservati per chi ha un abbonamento. Ho finito di ascoltare Ho conosciuto Kurt Cobain di Paolo Maoret e Marco Degli Esposti, un podcast indipendente di sette puntate che ripercorre i tragitti percorsi dal furgone dei Nirvana in Italia, dal tour del 1989 a quello mitico del ‘91. Ascoltalo <3.
Visioni. Non ho ancora iniziato a guardare M - Il figlio del secolo: aspetto che ci siano 3-4 puntate così vado diretta e me la godo di più. Ho finito The morning show (Apple TV) e quasi Non uccidere (Netflix). Tra i propositi del nuovo anno, c’è più cinema in sala. E per concretizzare il proposito in obiettivo, ho rinnovato la tessera Aiace. Il primo film visto è Diamanti, un capolavoro. Il prossimo? Ho Conclave in lista.
Tengo traccia dei libri che leggo su Goodreads. Ci sei anche tu?
🔎[Cosa stiamo facendo] Notizie dal mondo Kanji
Gennaio non finisce ancora. Qui proseguiamo con trasferte, incontri e piani di lavoro.
📍Informazioni di servizio
Cerchiamo di usare un linguaggio rispetto e inclusivo. Nel testo potresti trovare questo simbolo: « ǝ». Cosa significa? È un simbolo fonetico [schwa (o scevà)] utilizzato per non fare differenze, rispettando l’identità di genere di ognuno. Ne abbiamo parlato in una newsletter: voce del verbo includere.
Ogni tanto, nei consigli di lettura dei libri che leggiamo, o abbiamo letto, c'è un link con un codice di affiliazione. Questo significa che se clicchi e poi compri una di noi prende una piccolissima percentuale. È giusto e corretto che tu lo sappia e decida di conseguenza cosa fare. ;)
Vuoi condividerla? Puoi usare il bottone qui sotto.






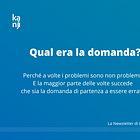
Grazie per la citazione e per questa bella puntata sull'importanza del farsi le domande giuste.